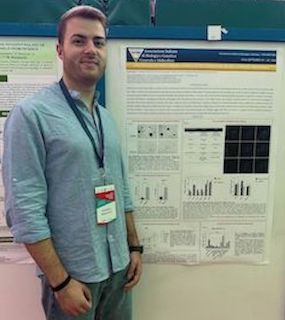Prosegue la carriera di divulgatore ad alto livello del professore Antonio Ereditato, che, con ‘Un breve viaggio chiamato Terra’. Come è iniziata la nostra vita e in quali modi potrà finire (editore Il Saggiatore) conferma la poliedricità già mostrata nei precedenti scritti, realizzati spesso in collaborazione con Edoardo Boncinelli. Anche in questo caso, l’obiettivo è centrato in pieno, grazie a una scrittura piana e comprensibile e a un ritmo alto in ogni capitolo, a tratti addirittura incalzante. Ereditato, scienziato a tutto tondo, riesce a comunicare senza il ricorso a formule o a linguaggi iniziatici, ma, alla maniera di Galileo, ci fa leggere il libro della natura grazie ai numeri. Per il fisico napoletano questi ultimi sono infatti alla base di ogni ragionamento, e diventano appoggio sicuro di teorie e speculazioni, esposte nel libro a distanza di sicurezza da astrattismi o autoreferenzialità. I numeri, si dice, sono testardi, e, forse anche per questo, l’autore indugia spesso sulle verità, a volte scomode, che essi disvelano riguardo all’emergenza climatica, consegnandoci un’opera oggettivamente pessimista, nonostante una percepibile volontà di segno opposto. Non sembra, quindi, casuale, l’introduzione fantacatastrofista, né il continuo indugiare sulla ‘fatale inadeguatezza’ delle classi dirigenti contemporanee. Per il professore Ereditato l’emergenza climatica è un problema da prendere estremamente sul serio e da considerare scientificamente acclarato. Una tesi prevalente, ma non unanime nella comunità dei suoi colleghi di varie branche del sapere.
Proprio nella ‘contaminazione’ tra diverse discipline si evidenzia, comunque, uno dei punti di forza più evidenti dell’opera. Non stupisce, quindi, l’acume sociologico mostrato dall’autore nell’analisi di un nuovo, caricaturale umanesimo, abbracciato dalle masse, né la puntigliosa precisione del racconto storico-antropologico relativo alle lunghe fasi della vita sulla Terra. Tanto meno sorprende la padronanza tecnica nel ‘maneggiare’ la geologia, con i suoi cataclismi, e la biologia evoluzionistica (della quale scopriamo in Ereditato un appassionato cultore), con tutte le sue propaggini, fino alla ricerca medica contemporanea. Discipline e tematiche ‘possedute’ dall’autore per il continuo ricorso al dubbio metodologico, alla base di qualsiasi percorso autenticamente scientifico. La casa madre rimane, tuttavia, l’astrofisica, raccontata da Ereditato con doti da incantatore, grazie a fascinosi viaggi nel tempo e nello spazio, o, meglio, ai confini dello spazio-tempo, suffragati da ferree impalcature matematiche (ancora numeri), in grado di legittimare i salti in avanti di una fantasia da grande cineasta, ma sempre controllata, e accompagnata da ‘puntuali proiezioni statistiche’, garanzia di un piacere ‘adulto’ anche per il lettore meno incline al genere. Una narrazione che coinvolge ancora di più quando si collega direttamente alla storia dell’uomo, come nel vivido racconto relativo agli astronomi cinesi medievali, ignari scopritori dell’esplosione di una supernova e della nascente nebulosa del Granchio.
A fine lettura, saturi di meravigliosa angoscia, ci si sente molto più consapevoli di un problema di cui tutti parlano, ma che pochi spiegano. Antonio Ereditato, anche in questa fase della sua carriera, rimane, per fortuna, un eccellente professore, capace di salire in cattedra e confrontarsi autorevolmente con la platea più ampia ed eterogenea della sua vita. Fidiamoci, quindi, dei suoi moniti sull’ineluttabilità di un’inversione di marcia retoricamente annunziata e mai avviata da quasi tutti i governanti del mondo. Fidiamoci del suo appello ad ogni ‘sapiens’ per un’azione congiunta e coordinata in difesa della nostra casa comune. Fidiamoci, infine, dell’urgenza di questa svolta. Il tempo a disposizione, ci spiega con chiarezza l’autore, è decisamente a portata di uomo.
Per i cataclismi geologici e climatici ‘strutturali’ o per gli innumerevoli disastri cosmici annunziati, sia pure su archi temporali più ‘rassicuranti’, o per la fine stessa della Terra, inevitabile tra qualche miliardo di anni, non ci resta, invece, che seguire ancora il laico Ereditato, con i suoi consigli e le sue speranze, ma al tempo stesso, ‘tradirlo’, guardando il cosmo alla ricerca d’altro.
Come dire: ‘‘aiutati, che Dio ti aiuta’’. In fondo, numeri alla mano, almeno una possibilità statistica può essere concessa anche alla sfera del trascendente.
Ettore Zecchino